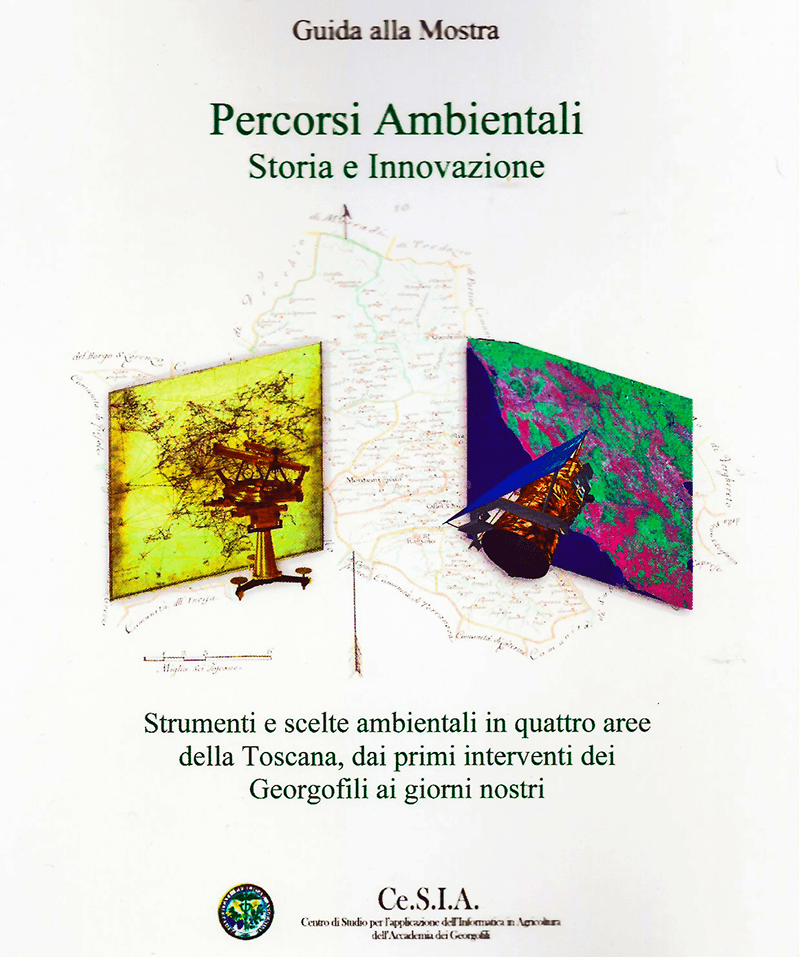
Indice
- Presentazione pag. 5
- Piano espositivo 7
- Inquadramento storico 7
- La diffusione del sapere scientifico, gli strumenti e l’osservazione della natura in Toscana 8
- La cartografia in Toscana dai Lorena ai giorni nostri 10
- Il ruolo dell’Accademia dei Georgofili nella gestione delle risorse ambientali 12
- Percorsi ambientali 13
- nell’Alto Mugello e nelle Foreste Casentinesi 14
- nelle colline del Chianti 17
- nella Maremma Grossetana 22
- nell’Arcipelago Toscano 26
- Il percorso documentale, cartografico, strumentale e iconografico 31
- Schede dei principali oggetti esposti
Mostra curata da:
Claudio Conese, Bernardo Rapi, Maurizio Romani, Piero Battista
Prof. Giampiero Maracchi
L’effetto dell’uomo sul pianeta nel suo insieme è sempre più evidente anche al di fuori dei circoli scientifici che da decenni avvertono l’incoerenza delle attività umane rispetto alle leggi della natura che regolano la presenza della biosfera sul pianeta. L’aumento della popolazione , Il massiccio uso di energia di origine fossile, l’impiego di molecole chimiche sempre più invadenti sono tutti elementi che pongono una serie di interrogativi rispetto alla sostenibilità a medio e lungo termine di questo sviluppo.
A questo si devono aggiungere altre preoccupazioni di carattere etico e politico che si applicano principalmente ai paesi industrializzati quali l’eccesso di consumi, che fa perdere di vista la distinzione fra i concetti di necessario, utile e superfluo, la tendenza ad una organizzazione della società che tende nuovamente a dividersi in due sole categorie i ricchissimi ed i poveri, secondo un modello simile a quello esistente prima della rivoluzione industriale, e la potenza dei mezzi d’informazione che riesce ad orientare le masse cancellandone qualsiasi capacità critica. La sudditanza della politica nei confronti dell’economia ha gravi conseguenze sulla governance pubblica che preferisce dedicarsi sempre di più agli interessi dei grandi gruppi economici e sempre meno alle esigenze dei cittadini, mentre la globalizzazione recide i legami con i territori di appartenenza e induce una perdita di valori tradizionali, maturati nel corso della storia, che mette in crisi gli stessi modelli organizzativi della nostra società, compresi quelli familiari.
La migrazione di milioni di persone alla ricerca di una risposta a condizioni di miseria presenti nei loro paesi d’origine, si scontra in molti casi con le asprezze di una realtà che li priva dei propri punti di riferimento e rende difficile una reale integrazione all’interno delle culture che li accolgono, spesso solo per necessità di una mano d’opera a bosso costo. Di questo risente anche la qualità del lavoro individuale, che tende a divenire sempre più anonimo e carente di motivazioni profonde, con la conseguente frustrazione di grandi masse di lavoratori, spinti verso il proprio destino soltanto dalla necessità.
Un fenomeno nuovo al quale si assiste è poi quello dell’allontanamento della finanza dall’economia reale, con la conseguenza che il denaro, che nasce come elemento di scambio di manufatti e di servizi, diviene sempre più svincolato dai beni materiali. S’innescano così processi perversi che generano improvvise crisi e privano in poco tempo i risparmiatori di risorse economiche prodotte nel tempo, dal lavoro e dal risparmio oculato, con una perdita progressiva di fiducia negli istituti bancari che divengono sempre di più meri intermediari di queste operazioni.
Come già accadde nel Rinascimento, nel quale filosofi, artisti, statisti e scienziati svilupparono una riflessione che un secolo più tardi dette avvio alla rivoluzione scientifica, tecnologica, industriale e politica, è necessario sviluppare una riflessione che ci permetta di costruire una nuova società, nella quale da una parte si consolidino le acquisizioni degli ultimi secoli e dall’altra si riducano gli impatti negativi, risolvendo le evidenti contraddizioni imposte dai meccanismi del mercato, cieco rispetto ai valori e spesso anche al semplice buon senso.
D’altra parte la natura dell’uomo è caratterizzata da una grande flessibilità e questa gli ha consentito di costruire scale di valori e modelli di comportamento completamente diversi da un’epoca all’altra. Il prevalere dei valori dell’economia nel XX secolo e delle lotte sociali a essa connesse, nonché l’identificazione dell’affermazione personale solo con i parametri economici, ha fatto perdere di vista molti altri aspetti della vita umana che oggi tendono a riemergere quale risposta a una crisi generalizzata del sistema economico e politico. Per comprendere meglio i fenomeni del secolo scorso è necessario delineare i caratteri salienti del modello economico corrente che si basa su di una produzione industriale sempre più concentrata in grandi gruppi, presenti in numerosi paesi, le cui decisioni sono sempre più svincolate dal potere politico e dal controllo sociale locale. Tale concentrazione si estende oggi anche al comparto bancario e finanziario che pur ricorrendo al risparmio dei privati, appare talmente lontano da non interpretare più un ruolo sociale come avveniva per gli istituti di credito locali.
Un altro settore sempre più sovranazionale è quello delle risorse naturali, prima fra tutte quella dell’energia, ma anche delle derrate agricole, dei minerali, dei prodotti chimici e farmaceutici. Gli strumenti attraverso i quali si pilotano le scelte dei consumatori sono rappresentati da una parte dai mezzi di comunicazione, che sono in grado per effetto del meccanismo della mimesi psicologica di influenzare larghi strati della popolazione, e dall’altra dalla globalizzazione del commercio, che vede nei centri commerciali i terminali nei quali si ammassano enormi quantità di merci provenienti da tutte le parti del mondo con conseguenza sugli stili di vita e di consumo.
La conseguenza di questa aggregazione economica e finanziaria al di sopra dei confini degli Stati crea una sorta di potere parallelo fuori da ogni controllo, che trae vantaggio dai meccanismi psicologici ed economici messi in atto per ridurre il potere critico e discrezionale dei singoli individui, giungendo ad influenzare le scelte della politica che sono sempre più dipendenti dagli attori dell’economia e della finanza globale.
Si perde così il radicamento delle comunità ai territori di appartenenza che non sono più, come nelle società preindustriali, la fonte principale dei mezzi di sussistenza, con una perdita significativa delle capacità necessarie all’elaborazione autonoma di modelli di società che valorizzino le esperienze individuali e collettive, rispondendo al criterio generale della diversità delle culture il cui contatto attraverso i commerci e le migrazioni costituiva un arricchimento reciproco.
In sostanza una sintesi delle profonde trasformazioni avvenute nell’ultimo secolo può essere compendiata dall’abbandono dalle aree rurali e dalla concentrazione in enormi megalopoli di milioni di persone e dunque dal passaggio da una civiltà prevalentemente agricola e rurale ad una civiltà prevalentemente urbana e industriale.
Una mostra come quella curata dal Ce.S.I.A. presso l’Accademia dei Georgofili si inserisce nel filone seguito dall’Accademia fino dalla sua fondazione, voluta dal Granduca per trattare con rigore scientifico i problemi economici, politici e sociali di quell’epoca.
Conoscere meglio il nostro passato e quei territori che ne sono stati i protagonisti, significa costruire nel modo migliore il nostro avvenire e soprattutto quello delle generazioni che verranno, per questo bisogna essere grati ai promotori e curatori della mostra per lo sforzo che hanno compiuto in questa direzione


